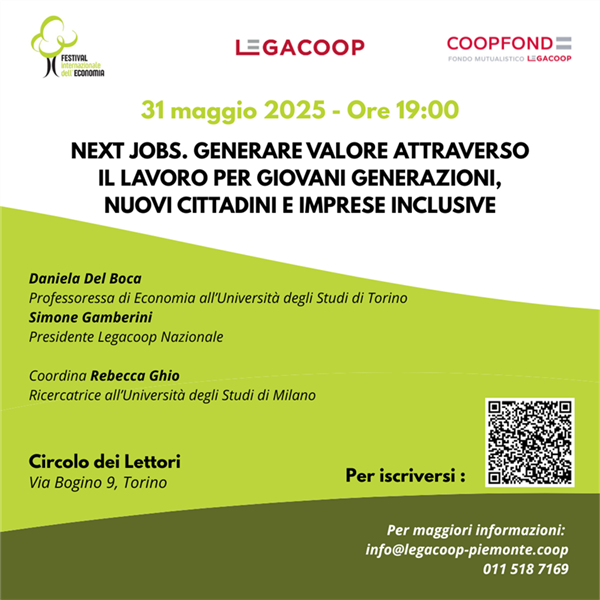Le cooperative come cantiere di pace
Di Danilo Valenti, presidente di Legacoop Umbria
In questi giorni, mentre a Gaza si intravedono timidi spiragli di dialogo tra Israele e Hamas, anche da Perugia abbiamo provato a parlare di pace. Lo abbiamo fatto con la consapevolezza che ogni passo, per quanto fragile, ha un valore universale: ci ricorda che la pace appartiene all’umanità intera. E da questa consapevolezza è nato un filo multicolore che dall’Umbria si è idealmente steso fino alla Palestina un filo intrecciato di parole, visioni e impegni concreti. La pace per non è solo un traguardo politico o un auspicio morale, ma un fatto economico, sociale e quotidiano. Un orizzonte concreto, che interpella le istituzioni, le imprese, la società civile, ognuno di noi. Ed è per questo che abbiamo messo al centro di “Verso la Biennale Umbria” un’importante questione: può l’economia diventare strumento di pace? Io credo di sì. Anzi, credo che oggi sia un dovere. Perché viviamo in un mondo che spende più per distruggere che per costruire, mentre sanità, istruzione e welfare restano sottofinanziate. La cooperazione, invece, con la sua storia e il suo modello, può essere il motore di un’inversione di rotta, liberare risorse dai conflitti e investirle nella cura delle persone e delle comunità.
Durante i lavori di questi giorni, i nostri ospiti hanno raccolto la sfida di rendere concreto un tema che troppo spesso viene relegato all’astratto. Ci hanno aiutato a guardare la pace non come un’utopia, ma come un progetto economico e civile che riguarda ciascuno di noi, ogni giorno, nel modo in cui lavoriamo, consumiamo, scegliamo.
Costruire un’economia di pace significa innanzitutto contrastare ogni spinta all’isolamento, rimettere al centro il dialogo, rifiutare la logica dell’odio e dell’indifferenza. Significa orientare risorse verso la ricerca, la transizione ecologica, la formazione, l’innovazione. Significa generare crescita che non escluda, ma includa. Perché l’economia della pace non è semplicemente il contrario di quella del conflitto. È una strategia di sviluppo fondata sulla cooperazione, sul benessere condiviso, sulla crescita sociale. È un’economia che mette al centro le persone e non il profitto, che misura il successo non solo in termini di PIL, ma di giustizia e felicità collettiva.
Eppure la realtà va in un’altra direzione. Il nostro Paese, nel triennio 2026-2028, prevede un aumento di 23 miliardi di euro per le spese militari, mentre sanità, scuola e servizi sociali non hanno risorse sufficienti. È una scelta che tradisce la gerarchia di valori della cooperazione. Perché un’economia che investe nelle armi ottiene vantaggi solo parziali, immediati e non lungimiranti, e paga un prezzo altissimo in termini sociali e morali.
Costruire un’economia di pace significa, allora, avere il coraggio di confrontarsi con chi è diverso da noi, di aprirsi a opinioni e interessi anche opposti, di praticare un dialogo profondo e autentico. È di questo sforzo ostinato al confronto che si nutre il pensiero civico. È qui che vive la democrazia: non negli slogan facili o negli sport dei “like”, ma nello spazio difficile del dialogo “vero”, quello che non teme la complessità.
Perché è proprio quel dialogo alto, complicato, coraggioso, la sostanza dell’antidoto più efficace contro la sopraffazione e l’abuso di potere. Un anticorpo necessario a tutte le società, anche quelle con una tradizione democratica più lunga.
La storia e la cronaca ci insegnano che pace e democrazia non sono mai conquiste definitive, ma richiedono impegno, sacrificio e coraggio. Noi crediamo che ne valga la pena. Perché costruire pace significa, in fondo, continuare a credere nell’essere umano: la cooperazione, con il suo linguaggio concreto e solidale, resta il cantiere aperto dove questa speranza può ancora prendere forma.